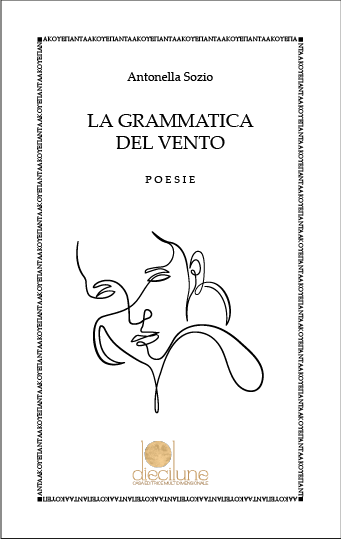Toponimi, nomi densi del loro sottofondo culturale, capaci di far apparire la profondità geologica della memoria che serbano. Nomi la cui pronuncia svela le verità inabissate di un luogo. Nomi che nell’evidenza che danno allo spazio ne condensano resistenze e disfatte. E poi nomi di persona e di animali, amati, distanti eppure presenti. In quest nuova raccolta di Antonella Sozio, il pulsare della vita si avverte nella precisione racchiusa dentro la sostanza concreta dei nomi propri, la cui vibrane realtà si offre allo sguardo e ai sensi apertissimi dell’io poetico, tutti tesi alla comprensione della vastità e all’imperativo di farne respiro, soggetto di nominazione, canto.
Se, come siamo portati a credere, la poesia può costituirsi quale terreno su cui l’io ritrova le proprie coordinate esistenziali, è nel loro posizionarsi entro un’aperta dimensione spaziale che i versi dell’autrice sannita restituiscono il sogno e la memoria, la fuga e il viaggio, il grido e il canto di «una vita perduta conficcata nelle spine del dire».
Ben lungi dai non luoghi della contemporaneità, il paesaggio e insieme il suo essere instancabilmente percorso e interrogato, sembra qui tradurre un’esperienza di profonda quanto dolorosa identificazione dell’io con l’ambiente naturale («così sono, così sei»), con la sua anima di fuoco, con il suo destino straziato in cui si coniugano resistenza e resa.
Riattualizzando tutto il dirompente stupore infantile e condensandosi intorno alla potenza evocativa dei nomi, l’incanto e il canto trovano i propri maestri nello zampillare degli elementi naturali: un fiore di campo, un pesce, un’onda, il verde, sono trattati alla stregua di spiriti guida e colti nella pronuncia solenne di un severo avvertimento all’indirizzo di una «ragione malata». Se è vero, infatti, che in questo paesaggio «nulla è che non sia canto e preghiera», è altrettanto vero che soltanto mettendo in crisi la supremazia di un discorso esclusivamente razionale, entro le cui reti il pensiero finisce per impigliarsi in congetture troppo spesso sterili, la sensibilità può aprirsi a un ascolto più semplice, dunque più diretto, non implicato nelle sovrastrutture della mediazione culturale. Quello della natura, dunque, attraverso la voce del vento che insiste indomito tra le pagine, «sembra canto ma è monito». Il paesaggio irrompe in questi versi da una prospettiva chiaramente assunta e percorsa: non mero oggetto di canto, non solo via di scandaglio nella ricerca delle proprie radici, ma semmai spazio di dilatazione ed effusione dell’io lirico. A tal riguardo, e quasi in forma ossimorica, proprio la questione delle radici, presente e insistita, assume una connotazione dinamica che ne capovolge e rivoluziona il senso, che le mette in cammino e le solleva sino all’altezza di una nuova utopia: «Le radici non sono circoscritte a terre anguste», si legge in una poesia il cui titolo eloquente, Non siamo stranieri mai, non consente al lettore margini di dubbio. Il riconoscersi fino all’identificazione con il paesaggio, il sentirsi parte di un tutto che trova la propria misura nell’immenso, può voler dire varcare i limiti del regionalismo, vuol dire radicarsi, certamente, ma secondo la lezione zanzottiana un radicarsi talmente profondo da trapassare i luoghi da parte a parte, da trapungerli fino a vederli nuovi, sradicandosi per radicarsi, distanziandosi per avvicinrsi al vero di quei luoghi. Mi pare interessante sottolineare, peraltro, che il lemma radice, nella sua occorrenza tanto al singolare quanto al plurale, è uno tra quelli che l’autrice fa danzare, in più d’un testo, attraverso figure retoriche d’iterazione, come a voler dare una sottolineatura ulteriore, anche sul piano formale, alla pregnanza di chiave di questa parola, non solo retorica e di senso, ma essenzialmente etica se, come si legge, è radice che «aspira a sollevarsi dal pantano».
Da ultimo, invito a riflettere sulle parole che aprono e chiudono questo libro. Ritengo rimarchevole che sia la parola Cammino a inaugurare la raccolta, preannunziando un metodo di appropriazione di tempo e di luoghi che così tanto è caro a tutta la nostra lunga tradizione letteraria. Così come mi sembra altrettanto significativo che, specularmente, sia la parola Poesia, in maiuscolo, in un verso che la contempla da sola, a essere posta in chiusura. Come a dire che l’esperienza biografica dell’io lirico protagonista di questi versi, un’esperienza segnata dalla perdita e dal distacco, dal dialogo con il trascorrere del tempo, un tempo che si vive senza possederlo, tra mutamento e ridondanze, tra strappi e ricomposizione, è un groviglio di vie (come rizomi di mangrovie) che può essere ricompreso e compreso entro uno spazio che è percorso a due vie, punto di partenza e approdo di ritorno. Come a dire che davvero per il poeta la parola, la lingua, la poesia può «costituire il “luogo” di un insediamento autenticamente “umano”», proprio come ci ha insegnato e continua a sollecitarci la riflessione di Zanzotto. Come ci sollecitano la poesia di Antonella Sozio e la sua «lingua del sorriso», lingua di ascolto lento e di silenzi attenti.